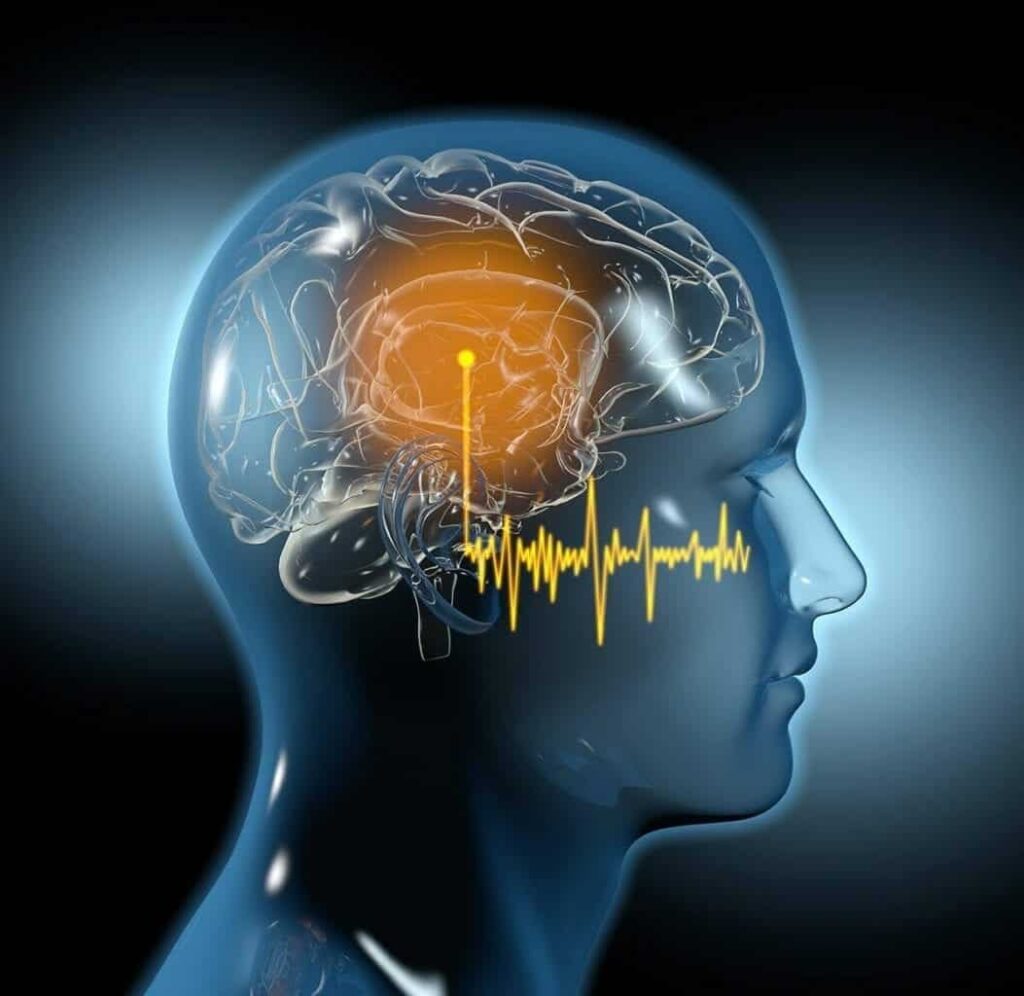
SUGGESTIVE NOVITA’ DAL MONDO DELLE NEURO-SCIENZE
importanza della “neuro-connettività funzionale” del nostro cervello
Ho scelto di iniziare questa esperienza di divulgazione, informazione ed aggiornamento con un
argomento che potrebbe diventare a brevissimo un punto nodale anche per il campo di specifico
interesse audiologico per medici e pazienti e che pertanto ha attirato recentemente la mia
personale attenzione. I neuro-scienziati di mezzo mondo pressati da assolute emergenze quali
quelle costituite dalle malattie neurodegenerative fino a ieri orfane di adeguate conoscenze ed
ancor di più di efficaci trattamenti preventivi e curativi stanno proprio in questi anni mettendo a
frutto nuovissime tecnologie e metodologie di studio sul Sistema Nervoso Centrale ed in
particolare sul Cervello; molti paesi sviluppati sia del mondo occidentale che di quello orientale
a tal fine si sono consorziati in network di studio avanzato (sotto l’etichetta generale di Brain
Projects) per concentrare gli forzi tecnologici ed organizzativi. Che sia un argomento
particolarmente interessante ne fa fede un nostro recente lavoro propositivo pubblicato su
Otorhinolaryngology e presentato nella relazione ufficiale sugli Acufeni del Congresso Nazionale
di Audiologia e Foniatria 2023 (*)
L’udito non è sicuramente una dimensione minore fra i complessi meccanismi sensoriali che
coinvolgono il nostro cervello, questo in certa misura già lo sapevamo ed anche su quel
misterioso disturbo chiamato Tinnitus o Acufene già da tempo avevamo chiare indicazioni di un
necessario coinvolgimento “centrale”. Come a molti è noto da anni si sa che il cervello è
suddiviso in aree cioè agglomerati di neuroni, che schematicamente, in un disegno non
estremamente complicato da comprendere, sono finalizzate a recepire e governare “dall’alto”
tutte le nostre funzioni una per una sia motorie che sensoriali anche le più periferiche, oltre che
contenere aree importanti per la nostra funzione cognitiva e psico-emozionale.
Il fatto è che solo negli ultimi anni si sono sviluppate tecnologie e strategie di studio grazie alla
modernissima bioingegneria medica, faccio riferimento per esempio alla fMRI Risonanza
Magnetica ad elevata potenza (7-8 volte maggiore di quella impiegata per la RM clinica
diagnostica) o altre metodiche dalle sigle più svariate (MEG, HD-EEG, fNIRS) altrettanto
suggestive, atte a visualizzare e monitorare non solo l’aspetto anatomico delle diverse aree del
cervello e delle stazioni e vie che sono anatomicamente connesse con esso ma anche le modalità
e l’estensione con cui queste aree si attivano e si disattivano in maniera estremamente
“dinamica” e come tali attivazioni-disattivazioni possono generare secondo meccanismi di
“neuro-connettività” parallele attivazioni-disattivazioni e modulazioni altrettanto dinamiche dei
neuroni di aree funzionalmente anche molto differenti da quelle di innesco primario, a volte in
maniera pressoché simultanea o comunque in tempi rapidissimi. In pratica si tratta della
possibilità di monitorare dinamicamente i microscopici cambiamenti funzionali o adattamenti
(sotto il generico termine di “neuro-plasticità”) di singoli raggruppamenti di neuroni in base ai
differenti input stimolatori ambientali o endogeni. Ma il panorama di intrecci e connessioni che
si sta man mano affacciando è reso più interessane oltre che complesso dalla dimostrazione che
il “traffico” di informazioni e relative attivazioni è in buona parte bidirezionale, dal cervello alla
periferia e dalla periferia al cervello, e nel nostro campo dall’orecchio al cervello e viceversa;
oppure in un circuito di andata dall’apparato muscolo-scheletrico al cervello e viceversa.
Secondo questo doppio scambio di stimoli e di informazioni, coinvolgendo le stazioni di neuroni
che si trovano lungo il percorso l’individuo si trova ad essere dotato di un sistema di controllo
estremamente raffinato top-down e bottom-up cioè dall’alto in basso e dal basso in alto. Nel
cervello stesso quasi sempre l’attivazione iniziale di un’area può determinare l’attivazione di
un’altra area o al contrario la sua disattivazione. Non è esclusa da tale intreccio, anzi ne è parte
a volte particolarmente attiva, l’area del cervello che si occupa delle nostre emozioni (area
“limbica” e amigdala). E non basta: gli “scambi di binario” fra una rete che dovrebbe portare alla
propria stazione o target di competenza ed un’altra rete che in effetti porta a stazioni diverse,
sono già possibili prima ancora di raggiungere il cervello lungo i vari percorsi (neuro-meccanismo
definito Cross-modale). Le reti uditive e l’area cerebrale uditiva sono fra le più impegnate in
questo articolato panorama.
Ora c’è da dire che tutto o quasi tutto dipende dalla tipologia di stimoli che arrivano al cervello:
questo è proprio il punto cruciale: la dimostrazione di connessioni attive ed interdipendenti e la
possibilità monitorare anche visivamente questo universo di neuroni e vie ha portato i
ricercatori a coniare il suggestivo termine di “CONNETTOMA” cioè l’insieme delle infinite
possibilità di connessioni ed interconnessioni funzionali del Sistema Nervoso Centrale, e quindi
quella che viene universalmente definita “connettività funzionale cerebrale” quale insieme di
meccanismi di creazione di network funzionali cerebrali attivati da funzioni semplici o
complesse (le moderne ricerche che hanno questo specifico obiettivo di studio generalmente
assumono il termine di Human Connectome projects già a partire dal 2008-2010). E’ interessante
sapere che non gestiamo questo complesso di connessioni tutti nello stesso modo anche se
stimolati da input simili in quanto pare che la predisposizione alla interconnessione cerebrale
abbia una base genetica e solo in parte “epigenetica” dipendente dall’ambiente, dagli stili di vita
dagli input multisensoriali ricevuti, ecc. Cioè ognuno avrebbe il proprio connettoma.
La stimolazione acustica e, oggi possiamo dirlo, la presenza di Acufeni fanno parte di questo
complesso gioco funzionale e la migliore conoscenza dei suoi meccanismi può essere veramente
alla base di più moderni e razionali metodi di approccio anche clinico; questo a mio modesto
parere ma anche secondo alcune delle ipotesi più accreditate. Il fatto che in molti dei più recenti
studi di connettività vengono oggi impiegati metodi di stimolazione acustica (gli stimoli visivi
sono impiegati da più tempo) e che gruppi di pazienti volontari con Acufeni e con problemi
uditivi vengono ultimamente impiegati negli studi ed osservazioni in molti centri che fanno
ricerca sulla connettività testimonia in prospettiva quanto ho appena affermato.
Si tratta di filoni di studio e ricerca che per la loro multidisciplinarietà e potenziale fruibilità
saranno sicuro oggetto della cosiddetta “medicina traslazionale”.
Da quanto sommariamente esposto grazie anche all’osservazione su tanti pazienti si sono
potute concepire nuove linee di interpretazione di fenomeni uditivi complessi come per es.
come gli Acufeni e l’Iperacusia e tentativi di elaborazione di protocolli diagnostici più razionali e
più rispondenti alle attuali conoscenze come quello elaborato dal mio gruppo pochi anni fa e
pubblicato sotto l’acronimo THoSC (Tinnitus Holistic Semplified Classification, Cianfrone et al)
(**) sottoposto a periodici aggiornamenti ma ancora base delle nostre strategie cliniche.
